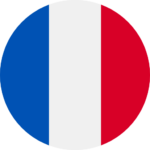Varie furono le ragioni che spinsero l’Italia fascista ad aggredire l’Etiopia, guidata dal Negus Neghesti (imperatore) Hailé Selassié ed unico Stato africano rimasto indipendente assieme alla Liberia, che costituiva però, a tutti gli effetti, una creazione coloniale. Innanzitutto, il Regime desiderava conseguire l’agognato successo internazionale, che ne consolidasse il prestigio interno ed estero. In questo modo, voleva anche vendicare l’umiliante sconfitta subita nel 1896 ad Adua dall’«Italietta» liberale (come veniva sprezzantemente definita l’Italia giolittiana dai nazionalisti). A questo, si affiancava il desiderio di disporre di un territorio del quale sfruttare le presunte risorse, specie agricole, indirizzandovi la manodopera in eccesso, presente sul territorio nazionale.
Le operazioni militari propriamente dette si protrassero dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e, malgrado il coraggio e l’abnegazione mostrati dai soldati abissini, terminarono con l’occupazione della capitale Addis Abeba e con la vittoria delle truppe italiane, forti di una superiorità numerica e tecnologica soverchiante. Sin dalle fasi iniziali del conflitto, il fascismo aveva, inoltre, manifestato la volontà di condurre una vera e propria campagna di sterminio ai danni del nemico. La Regia Aeronautica arrivò ad utilizzare persino i gas asfissianti (proibiti dalla convenzione di Ginevra), quali l’iprite e il fosgene, che provocarono migliaia di vittime in una popolazione del tutto priva di difese contro gli aggressivi chimici.
Scarsissimo sostegno ricevette il Negus dai tradizionali alleati francesi e britannici, poco propensi ad inimicarsi Mussolini, e anche le sanzioni economiche comminate all’aggressore dalla Società delle Nazioni – della quale l’Etiopia faceva parte sin dal 1923 – si rivelarono del tutto infruttuose, contribuendo anzi a diffondere in Italia uno spirito di unione nazionale che venne abilmente cavalcato dalla propaganda del Regime. Fu proprio in questo periodo che raggiunse il picco di consenso tra la popolazione e approfittò del clima creatosi, per mettere in atto un’ulteriore stretta repressiva ai danni degli oppositori, che si concretizzò in un’ondata di denunce al Tribunale Speciale e alle commissioni per l’ammonizione e il confino.
La brutalità dei colonizzatori non venne meno con la fine ufficiale delle ostilità, toccando anzi nuove vette in concomitanza con il precoce emergere di un movimento di resistenza nazionale all’interno del popolo assoggettato. All’indomani del fallito attentato al viceré Rodolfo Graziani, la violenza fascista si scatenò prima contro l’inerme popolazione di Addis Abeba, poi contro il clero cristiano copto residente nel convento di Debre Libanos, provocando in pochi giorni il massacro di circa 19.000 etiopi.
Tuttavia, a dispetto delle stragi, delle deportazioni e di un rinnovato utilizzo di armi chimiche da parte dell’occupante, gli arbegnuoc (i «patrioti», così si definivano i guerriglieri abissini) continuarono la lotta, dando filo da torcere alle autorità italiane e, in seguito, collaborando con le truppe britanniche fino alla riconquista finale del Paese e al trionfale ritorno di Hailé Selassié ad Addis Abeba il 5 maggio 1941.