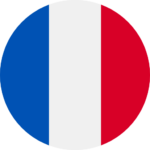Qualche anno fa in occasione del 20 Luglio, un consigliere comunale del PD di Ancona, Diego Urbisaglia, ha scritto su Facebook un post sui fatti del G8 di Genova affermando che se suo figlio fosse stato al posto di Mario Placanica, il carabiniere che uccise Carlo Giuliani, gli avrebbe detto «di prendere bene la mira e sparare». «Sì, sono cattivo e senza cuore, ma lì c’era in ballo o la vita di uno o la vita dell’altro. Estintore contro pistola. Non mi mancherai Carlo Giuliani». «Non commento queste affermazioni» è stata la civile reazione di Giuliano Giuliani, il padre di Carlo. Secondo la madre, Heidi, «quel signore si deve solo vergognare».
Il ricordo di quelle giornate del luglio 2001 ha sempre spaccato in due l’opinione pubblica.
Un clima da costante «guerra civile fredda», come da definizione di Daniele Luttazzi, sembra essere il tratto caratteriale principale del nostro paese. Nel 2011 Giuliano Pisapia, già legale della famiglia Giuliani e allora sindaco di Milano, scrisse un post per ricordare la figura di Carlo, «un ragazzo che sognava un futuro migliore per il nostro paese e per il mondo, cui sentiva di appartenere e che desiderava più giusto, più libero, più democratico». Tra i commenti si distinse per particolare ferocia quello che definiva il ragazzo uno «che non lavorava» e per questo «ha meritato di morire». «Mi piace ricordarlo con un buco in testa e steso sull’asfalto»: di tale tenore i commenti apparsi sulla pagina Facebook del fumettista Zerocalcare, nel luglio del 2016, sotto un post in cui annunciava la sua partecipazione alla commemorazione che si tiene ogni anno a Genova, nell’anniversario della morte di Carlo.
Alla radice di tale livore c’è sicuramente l’ignoranza dei fatti, così come sono stati accertati nei lunghi 16 anni che ci separano da quei giorni. «All’italiano medio piace credere di sapere» – facciamo nostre le parole dello scrittore Girolamo De Michele – che a Genova centinaia di migliaia di manifestanti impazziti devastarono a destra e a manca, e tra questi Carlo Giuliani che assaltava un Defender dei Carabinieri, mentre le forze dell’ordine erano costrette a difendersi. Non è andata così. È falso.
Se non si allarga lo sguardo all’intera vicenda è impossibile comprendere perché Giuliani si trovasse con un estintore vuoto in mano sotto quel Defender, e perché Amnesty International ha affermato che in quei giorni avvenne «la più grande sospensione dei diritti democratici in un paese occidentale dopo la seconda guerra mondiale». Una sospensione dello stato di diritto, di fatto, avallata dai vertici della polizia e dal governo.
LA GUERRA DI GENOVA
Genova. 20-22 luglio 2001. I giorni del summit degli otto paesi più industrializzati del mondo, il G8. In città erano previste le manifestazioni del movimento “no-global”, nato e cresciuto a partire dalla storica dimostrazione di Seattle, del novembre del 1999, contro la conferenza dell’Organizzazione mondiale del commercio. Si trattava di un movimento eterogeneo composto da ambientalisti, pacifisti, cattolici, comunisti, anarchici, squatters, ma anche tanta gente comune, uniti nella contestazione della politica economica globale. Erano attesi a Genova manifestanti da tutto il mondo e il governo – il peggiore governo della storia repubblicana – guidato da Silvio Berlusconi prese imponenti misure di sicurezza. Il clima era teso. Da mesi giornali e televisioni parlavano della «guerra di Genova» in termini deliranti, “rivelando” che i manifestanti avrebbero fatto uso di armi quali palloncini di sangue infetto e frutta ripiena di lamette da barba. Oggi sappiamo che si trattava di veline diffuse dai servizi segreti, ma allora furono pochi i media che avanzarono dubbi. Il tam-tam incedeva particolarmente sul pericolo rappresentato dalle azioni vandaliche del Black-bloc.
E infatti quella che accolse i manifestanti era una città fantasma. Negozi chiusi. Strade deserte. Forze dell’ordine ovunque. Il centro della città, la “zona rossa”, era inaccessibile, chiuso dentro un perimetro di cancellate di ferro. Chiusi porto e ferrovie, all’aeroporto, dopo l’arrivo dei capi di stato, furono predisposti missili terra-aria per timore di attentati terroristici.
Il 19 luglio si tennero il corteo per i diritti dei migranti e il concerto di Manu Chao.
Il 20, l’inferno. Nel primissimo pomeriggio, mentre sparuti gruppi di manifestanti creavano disordini – assolutamente contenibili dallo spiegamento di forze messo in campo – assaltando il carcere di Marassi, banche e supermercati, le forze dell’ordine intervengono prima in piazza Manin, caricando violentemente i cattolici e pacifisti della Rete Lilliput – gente con le mani alzate pitturate di bianco che cantava inni di oratorio – e poi il corteo delle Tute bianche.
C’era un “accordo” tra le Tute bianche, i centri sociali italiani più “moderati”, e la Questura. Il corteo sarebbe arrivato fino alla zona rossa e un manifestante l’avrebbe, simbolicamente, invasa. Le prime file delle Tute bianche si proteggevano dietro scudi di plexiglas perché qualche manganellata era prevista. Invece, alle due del pomeriggio i manifestanti, percorrendo via Tolemaide, giunsero a un vicolo cieco. Di fronte le forze dell’ordine schierate. Il corteo, autorizzato, fu attaccato più volte e senza alcuna ragione dai Carabinieri, anche dalle vie laterali. Ristabilendo l’ordine cronologico, decisivo per un giudizio oggettivo di quanto accaduto, si può dire che fu la prima violazione gravissima avvenuta in quei giorni, la negazione dell’elementare diritto a manifestare in un luogo pubblico. I manifestanti trovarono vie di fuga e non ebbero altra scelta che quella di reagire. Fino al tramonto fu guerriglia. Le immagini riprese in quei momenti, e trasmesse dalle televisioni di tutto il mondo, mostrarono le forze dell’ordine che attaccavano i manifestanti con lacrimogeni urticanti, manganelli tonfa impugnati al contrario per fare più male, spranghe non in dotazione e mezzi blindati lanciati a grande velocità sulla folla.
La sera stessa don Andrea Gallo, in diretta televisiva, definì quella del pomeriggio una «imboscata» tesa per spingere i manifestanti a una reazione. Dall’attacco al corteo autorizzato scaturirono i disordini che degenerarono nei fatti di piazza Alimonda, dove trovò la morte Carlo Giuliani.
La dinamica di quegli eventi è, ormai, tristemente nota.
Un Defender dei Carabinieri, in fuga dopo una carica abortita, rimase indietro e fu preso d’assalto da alcuni manifestanti inferociti da tutta quella violenza gratuita. Tra loro, Carlo – che quel giorno rinunciò ad una prevista gita al mare per dirigersi al corteo – con il volto coperto da un passamontagna, raccolse da terra un estintore vuoto, già scagliato contro il mezzo da un altro manifestante, e lo sollevò. Dall’interno del veicolo il carabiniere di leva Placanica sparò due colpi. Uno raggiunse Carlo alla testa.
Il fuoristrada, riprendendo la manovra, passò sul corpo di Carlo. Due volte. Erano le 17 e 30. Poco più tardi una donna delle forze dell’ordine, al telefono con un collega, commentava: «Speriamo che muoiano tutti. Intanto, uno a zero per noi!».
L’autopsia, oltre al colpo di arma da fuoco, rivelò una profonda ferita irregolare sulla fronte di Giuliani. Secondo la ricostruzione del sito piazzacarlogiuliani.org – che raccoglie le più interessanti inchieste indipendenti che sono state realizzate su piazza Alimonda – quella ferita fu prodotta da un carabiniere che cercò di creare artificialmente una prova che Carlo era stato ucciso da un sasso lanciato dai manifestanti. È una tesi sposata anche dai genitori di Carlo fondata su testimonianze fotografiche di quei momenti. In quegli attimi un agente accusò un manifestante di avere ucciso Carlo. «Bastardo! Lo hai ucciso tu col tuo sasso, pezzo di merda!». Un fotografo fu massacrato a manganellate perché colpevole di aver fotografato – troppo presto e da vicino – il corpo. Le sue apparecchiature furono metodicamente distrutte. In una telefonata registrata un carabiniere sul posto disse al generale che lo interrogava che Carlo era stato investito, che forse era stato colpito da un sasso o forse da un proiettile.
Poco dopo la morte di Carlo, alle 18, le forze dell’ordine parlarono in conferenza stampa di un manifestante spagnolo probabilmente ucciso da un sasso, ma pochi minuti dopo le agenzie cominciarono a diffondere le prime dichiarazioni dei medici che confermavano uno sparo come causa del decesso. Frattanto Placanica – lo ha raccontato a “CalabriaOra” nel novembre 2006 – fece rientro in caserma. «Mi chiamavano “il killer”. I colleghi hanno fatto festa». «“Benvenuto tra gli assassini” mi hanno detto». «Cantavano canzoni e hanno fatto una canzone su Carlo Giuliani». Anche il corteo del giorno dopo fu attaccato dalla polizia. In corso Italia, sul lungomare di Genova, non si fecero distinguo: uomini, donne, anziani e ragazzini furono manganellati da agenti di polizia e si ritrovarono col volto pieno di sangue.
La sera del 21, il G8 era terminato e mancavano pochi minuti alla mezzanotte, un plotone fece irruzione alla scuola Diaz. Nella palestra dell’edificio riposavano alcuni manifestanti, molti stranieri. Agenti in assetto antisommossa circondarono l’edificio per tenere lontani i giornalisti. Da un passo del libro La ferita di Marco Imarisio, cronista del “Corriere della Sera”: «Cominciarono a uscire le barelle dalla scuola. Una dopo l’altra. Un ragazzo dai capelli neri era riverso su un fianco, svenuto, la maglietta lacerata e intrisa di sangue. Una ragazza con i dreadlock che sembrava morta, il braccio destro le penzolava dalla lettiga, aveva le guance imbrattate di sangue. E poi gli altri. A ogni apparizione la situazione diventava sempre più chiara, il perché di quelle urla che uscivano dalle finestre al primo piano sempre più lampante. E quel coro che diventava sempre più martellante. “Assassini, assassini”».
Alla Diaz fu un massacro. Dentro la scuola sangue ovunque. Chiazze di sangue vivo sul pavimento, strisciate di sangue sulle pareti, grumi di sangue sui termosifoni. Un giornalista inglese, Mark Covell, è vivo per miracolo. Con un calcio nel petto gli sfondarono la gabbia toracica, fracassando 6 costole, per un calcio in bocca perse 12 denti. Mentre nella Diaz andava in scena «una rappresaglia di stile cileno», nella scuola Pascoli – in quei giorni sede del centro stampa del Genoa Social Forum, organizzatore della manifestazione – gli agenti distruggevano materiale filmato e fotografico, le prove delle violenze di quei giorni.
Il mattino dopo il blitz due bottiglie molotov furono mostrate a cronisti e fotografi per sostenere la tesi che la Diaz era un covo di manifestanti violenti e che quella irruzione era doverosa. Dei feriti che uscivano dalla scuola in barella si disse che era gente che si era fatta male durante gli scontri della giornata. Ma le indagini successive provarono che le molotov erano state introdotte nella scuola dalle forze dell’ordine. Ritrovate la mattina precedente, non fu redatto il verbale di sequestro e si cercò di accollarle a chi stava alla Diaz. Prove false.
Ha affermato una vittima di quella notte: «Devo dire che, nonostante la grande sfortuna di essermi ritrovato in quella situazione, sono stato fortunatissimo perché ho preso tante di quelle mazzate che sono andato direttamente in ospedale e non mi hanno portato a Bolzaneto».
Del centinaio di arrestati fatti alla Diaz, quasi tutti erano feriti. Poco più della metà di essi furono ricoverati in ospedale, gli altri finirono alla caserma di Bolzaneto dove furono, ancora, vittime di soprusi gravissimi. Leggere la requisitoria dei pubblici ministeri di Genova su quanto accadde lì dentro, fondata su più di 200 deposizioni, è impressionante. Calci, pugni, schiaffi, manganellate, sputi, spintoni, spruzzate di spray urticante sulle ferite aperte, teste sbattute contro il muro. Oltre alle percosse gli arrestati furono anche vittime di minacce, offese, insulti politici, soprusi fascisti: «Froci di merda»; «puttane»; «comunisti bastardi»; «vediamo se Bertinotti e Manu Chao vengono a salvarvi»; «viva il duce»; «heil Hitler»; «benvenuti ad Auschwitz»; gli agenti recitavano filastrocche come «1-2-3 viva Pinochet, 4-5-6 a morte gli ebrei», imponevano ai fermati di fare il saluto romano e di dire «sono una merda». In sottofondo cantilene come «faccetta nera» o «te gusta il manganello». Una ragazza con il piercing vaginale fu obbligata a rimuoverlo davanti a numerose persone. Una persona che aveva una mascella rotta, mentre stava facendo i bisogni, fu spinta a terra. Un’altra chiese di andare in bagno, le venne negato, e fu costretta a farsela addosso. Un’altra ancora fu obbligata a mettersi carponi e ad abbaiare come un cane. A una donna furono negati gli assorbenti e fu costretta ad arrangiarsi con una maglietta strappata. A una madre venne mostrata la foto dei suoi figli con la minaccia che se non avesse firmato il verbale del suo arresto non li avrebbe visti tanto presto. Fortunatamente nessun caso di violenza sessuale, ma ci furono state minacce di stupro sia per le donne che per gli uomini, con l’uso di bastoni o manganelli. Un ragazzo, in infermeria, nudo, fu vittima di battute legate all’aspetto del suo membro. «Carino il comunista, ce lo facciamo?». Tra i testimoni di quell’orrore, Marco Poggi, infermiere penitenziario in servizio quella notte, denunciò le torture, raccontandole nei dettagli. «L’infame» subì numerose minacce.
I PROCESSI
Ma quali furono le conseguenze processuali di quelle giornate?
Mario Placanica è stato indagato per omicidio e poi prosciolto perché, secondo la giustizia italiana, agì per legittima difesa. La Corte europea dei diritti dell’uomo, alla quale la famiglia Giuliani ha fatto ricorso, ha accolto la ricostruzione italiana ma ha disposto un misero risarcimento ai familiari di Giuliani, criticando la mancata realizzazione di un’inchiesta adeguata sulle circostanze della morte del giovane e la mala gestione dell’ordine pubblico durante il vertice.
Nel 2012 la Corte di Cassazione ha confermato le condanne per 25 persone, tra agenti e funzionari di polizia, per l’irruzione alla Diaz, disponendo un risarcimento per le vittime del pestaggio. Sono andati tuttavia in prescrizione i reati di lesioni e sono state eseguite solo le condanne per falso. Falso sulle molotov e falso sulle aggressioni subite dentro la scuola, come quella denunciata dal poliziotto che raccontò di aver ricevuto una coltellata. È notizia di qualche settimana fa che alcuni dei condannati – che, secondo la Cassazione, «gettarono discredito sulla Nazione agli occhi del mondo intero» – potranno a breve chiedere il reintegro in ruolo e indossare nuovamente la divisa, perché scontati i 5 anni di interdizione dai pubblici uffici.
Con 7 condanne si è chiuso il processo sugli gli abusi di Bolzaneto. Nel verdetto d’appello, i giudici avevano dichiarato prescritti i reati contestati a 37 imputati tra poliziotti, carabinieri, agenti penitenziari e medici, riconoscendoli comunque responsabili sul fronte dei risarcimenti. I giudici hanno confermato che a Bolzaneto furono commesse gravi violazioni dei diritti umani, ma la prescrizione ha comportato la sostanziale impunità per molti degli imputati, anche per la mancanza del reato di tortura nel codice penale italiano. Solo recentemente infatti, lo scorso luglio, una legge sulla tortura è stata approvata dal Parlamento italiano. Una legge tuttavia contestata da alcuni magistrati impegnati proprio nei processi genovesi, perché non sarebbe applicabile a un nuovo caso Bolzaneto.
Nel luglio 2012 sono state infine confermate definitivamente le condanne – che vanno dai 6 ai 15 anni – per 5 dei 10 manifestanti sotto processo. Per gli altri si dovrà solo riesaminare la concessione delle attenuanti generiche. Sono stati riconosciuti colpevoli di «devastazione e saccheggio». Si tratta di una disposizione introdotta durante il regime fascista che si caratterizza per la vaghezza con cui definisce il reato. Era infatti un arma giudiziaria che poteva essere utilizzata a discrezione del regime per il mantenimento dell’ordine dittatoriale. Pochi giorni dopo la sentenza, Miguel Gotor commentava su “Repubblica”: «Si ha l’impressione di un uso astratto e simbolico della giustizia che ha voluto caricare sulle spalle di queste cinque persone tutto il peso e la responsabilità di quanto è avvenuto a Genova in quei giorni. Il classico capro espiatorio. Tra l’impunità totale per quei rappresentanti delle forze dell’ordine che hanno seviziato degli esseri umani senza scontare un solo giorno in prigione e la condanna a 14 anni di carcere per chi ha rotto una vetrina, sottratto generi alimentari da un supermercato o tirato pietre, era doveroso trovare un giusto mezzo”.
GENOVA NON È FINITA
Dopo la chiusura dei processi che cosa resta di Genova, oggi? Sicuramente un senso diffuso di ingiustizia e una grande sofferenza umana. Tra le vittime delle violenze poliziesche c’è chi è morto suicida, chi ha subito gravi conseguenze fisiche, chi soffre di disturbi o traumi cronici che impediscono di svolgere una professione, chi di depressione. Hanno ancora incubi ricorrenti i torturati di Genova. E per molti è impossibile approcciarsi con serenità alle forze dell’ordine, senza subire attacchi di panico. Resta anche una forte sfiducia nella partecipazione politica. Secondo Daniele Vicari – regista di Diaz, un coraggioso film che mostra quanto accaduto in quei giorni – intervistato nel luglio 2016 da “Left”, gli eventi di Genova «hanno mostrato a tutti cos’è uno Stato autoritario». Per Vicari «la pratica della tortura di massa da parte di centinaia di persone in divisa che rappresentano lo Stato italiano» è «un vulnus alla democrazia così macroscopico da diventare uno dei motivi per cui oggi lo Stato e la politica sono in crisi, perché hanno perso totalmente di credibilità e non solo agli occhi delle vittime».
Due terzi dei dimostranti di Genova era alla prima grande manifestazione e la maggioranza di loro, alle manifestazioni, non ci va più. Ma delle giornate di Genova ci restano anche le ragioni dei no-global, 300.000 persone che ci misero in guardia da una serie di problemi che minacciavano il nostro futuro: riscaldamento globale, disuguaglianza sociale, politiche migratorie sbagliate e diffusione di xenofobia e razzismo, dominio della finanza sull’economia, aumento del potere del privato sul pubblico, delle multinazionali sugli stati, delle lobby sui parlamenti, assottigliamento dei diritti dei lavoratori. La crisi doveva ancora arrivare ma quel movimento aveva previsto tutto. Carlo Giuliani – un ragazzo che frequentava i centri sociali, che giocava a calcetto in parrocchia, che leggeva “Dylan Dog” e la “Gazzetta dello Sport”, che tifava per la Roma, la squadra della città in cui era nato – aveva ragione. E ha pagato per questo.
Recentemente Franco Gabrielli, l’attuale capo della polizia italiana, in una intervista rilasciata “Repubblica”, ha ammesso che «a Genova, un’infinità di persone, incolpevoli, subirono violenze fisiche e psicologiche che hanno segnato le loro vite. E se tutto questo, ancora oggi, è motivo di dolore, rancore, diffidenza, beh, allora vuol dire che, in questi sedici anni, la riflessione non è stata sufficiente. Non è stato messo un punto. Il momento di mettere questo punto è arrivato». Sono dichiarazioni importanti che, tuttavia, perdono valore se nella stessa intervista si afferma che «la Polizia italiana è sana, oggi, come lo era in quel luglio del 2001».
Come abbiamo visto, le forze dell’ordine, sostanzialmente, non hanno pagato per la mattanza di Genova. Lo Stato italiano le ha assolte. Commentando l’esito dei processi, Amnesty International ha denunciato la «vergognosa mancanza di assunzione di responsabilità per i fallimenti politici e sistemici che hanno reso possibili le violenze» sottolineando come non siano mai stati adottati «procedimenti disciplinari significativi». Ha scritto lo storico Angelo D’Orsi, nel 2011, su “MicroMega”: «I poliziotti incarnarono le peggiori ingiurie che sono abituati a sentire al proprio indirizzo. Furono davvero sbirri boia, furono macellai, furono criminali in libera azione contro una massa di persone indifese, innocenti. Una macchia indelebile sulla divisa di agenti, carabinieri, finanzieri e quant’altro. Una macchia che fu sporcata di sangue. Una macchia intrisa di menzogna, detta e reiterata fino ai nostri giorni. Una macchia che è stata addirittura lucidata con le promozioni di taluni personaggi che avrebbero dovuto esser radiati dai ranghi di qualsiasi pubblica amministrazione».
La politica, sui fatti di Genova e sulle responsabilità di chi gestì l’ordine pubblico ha sempre rinunciato a indagare con i poteri della commissione di inchiesta. Non ha indagato il centrodestra e non stupisce. I fascisti di quella maggioranza dirigevano le operazioni dalle sale comando delle forze dell’ordine in quei giorni. Non lo ha fatto il centrosinistra, nonostante lo avesse promesso. Le forze dell’ordine sono state contro la magistratura in ogni fase dei procedimenti giudiziari. Nonostante Genova, sono intoccabili. E dopo Genova questa impunità è stata all’origine di altre tragedie come quella di Federico Aldovrandi, o quella di Stefano Cucchi. Storie di verbali truccati, testimonianze insabbiate, prove occultate, che rivelano come le forze dell’ordine siano capaci di fare male, il male assoluto, perché certi di farla franca, rovesciando le colpe sulle vittime.
Gabrielli, per essere credibile, faccia seguire gesti concreti alle sue riflessioni. Magari spingendo per l’adozione di quei punti che Lorenzo Guadagnucci, giornalista, vittima della Diaz, presidente del Comitato verità e giustizia per Genova e nipote di una vittima della strage nazista di Sant’Anna di Stazzema – l’eterno ritorno della storia – ha proposto per una credibile riforma democratica delle forze dell’ordine: smilitarizzazione (oggi il 100% delle nuove assunzioni avviene per legge fra chi è stato volontario nelle forze armate) e apertura alla società civile; una legge sulla tortura credibile e una norma che renda identificabili, con codici sulle divise, gli agenti in servizio di ordine pubblico; l’istituzione di un’autorità indipendente, con poteri d’indagine e sanzionatori, che affianchi l’eventuale azione penale della magistratura contro le forze dell’ordine, che hanno dimostrato di non essere capaci di compiere serie verifiche interne dei propri comportamenti: lo spirito corporativo, di fronte a denunce di abusi, prevale regolarmente sull’esigenza di giustizia e di trasparenza; la collocazione immediata dei condannati a ruoli che non comportino una relazione diretta con i cittadini; introduzione, nelle scuole di polizia, della formazione sui diritti di cittadinanza e sui metodi nonviolenti per la gestione dei conflitti. Perché si ponga fine, una volta e per tutte, agli abusi in divisa.
Alberto Di Maria