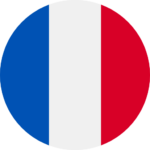La pandemia da coronavirus in poche settimane ci ha insegnato ciò che movimenti ambientali, sociali, pacifisti, provano a dirci da decenni: la svolta verde non è procrastinabile; le politiche sanitarie non possono sottostare alla logica del profitto; le spese militari non portano sicurezza; la solidarietà sociale e internazionale sono imprescindibili sempre, non solo quando se ne ha bisogno; l’istruzione ha un’importanza fondamentale nella vita, non solo formativa, di bambini e giovani. Il più grande sconvolgimento del secolo non è arrivato su un barcone a Lampedusa, è sbarcato dalla business class a Malpensa. I vincoli di bilancio e i parametri di Maastricht, intoccabili totem fondativi dell’economia UE, sono caduti assieme alle borse mondiali. Addirittura il “Financial Times” scriveva nel fondo del 3 aprile: “Bisognerà mettere sul tavolo riforme radicali, invertendo la tendenza che ha prevalso negli ultimi quarant’anni. I governi dovranno accettare di svolgere un ruolo più attivo nell’economia. Dovranno considerare i servizi pubblici come un investimento anziché un peso, e cercare di rendere meno precario il mercato del lavoro. […] Bisognerà prendere in considerazione misure che fino a ieri sono state considerate stravaganti, come il reddito di base e le tasse patrimoniali”.
In questo periodo molti commentatori hanno fatto riferimento a situazioni critiche del passato, dall’epidemia di “spagnola” alla crisi del ’29, alla seconda guerra mondiale. Da parte nostra, forse per lunga frequentazione di chi ha vissuto in prima persona l’antifascismo e la Resistenza, il parallelo che salta alla mente si colloca in quella fase incerta e tormentata in cui era evidente la necessità di combattere per uscire da una situazione non più sostenibile, senza però sapere quando il nuovo ordine sarebbe arrivato, e che volto avrebbe avuto. Nel frattempo, anziché attendere gli eventi, le migliori menti di diversa estrazione sociale e politica iniziarono a progettare la società dell’avvenire, partendo dalla facile identificazione di ciò che andava smantellato (in una parola, il fascismo, con tutte le sue aberrazioni politiche, economiche, sociali e culturali), per poi porre le basi di un nuovo contratto sociale. Forse per la sua condizione di focolaio del contagio fascista, a questa elaborazione il contesto italiano offrì il contributo maggiore, come ben rappresentano la Costituzione Repubblicana e il cosiddetto Manifesto di Ventotene. Ma, appunto, quegli ideali e quei progetti sarebbero rimasti nei sogni o sulla carta, se non avessero affiancato una battaglia che considerava la sconfitta del nazifascismo il prerequisito per una più ampia conquista democratica che impedisse il ritorno del mostro.
Oggi, complice il linguaggio militarista abusato per la “guerra al coronavirus”, potremmo avere l’illusione che “la vittoria” sia semplicemente l’uscita dalla pandemia, dal lockdown, il “ritorno alla normalità”. Ma è proprio quella normalità che ci ha portato la pandemia. Non ci sarà nessun risultato duraturo senza una consapevolezza simile a quella maturata durante gli anni dell’antifascismo militante e della lotta partigiana, capace di farci immaginare e progettare un futuro differente. In caso contrario, ci predisporremmo solo ad attendere il prossimo virus, le prossime emergenze, i prossimi lutti. Nella realtà odierna, pur appesantita dalle avversità che sappiamo, godiamo comunque del vantaggio di non rischiare una mitragliata, il confino, un bombardamento, o di essere caricati su un vagone piombato. Allo stesso tempo, traendo insegnamento da quella Storia, non possiamo permetterci l’ignavia di lasciare la progettazione dell’uscita dal periodo eccezionale al coacervo di ideologie che ha disegnato il nostro vivere comune in questo primo quinto di secolo. Se così fosse stato nei primi anni ’40, difficilmente avremmo avuto la Repubblica parlamentare e il protagonismo delle masse; più probabile, allora, ritrovarsi Umberto II Savoia con uno Statuto albertino (forse) riformato, e la stessa borghesia industriale sostenitrice del fascismo a disegnare i “nuovi” rapporti socioeconomici del dopoguerra.
Nell’affrontare l’inizio della fase emergenziale, le prime chiusure hanno riguardato gli asili e le scuole di ogni ordine e grado, le università, i cinema, i teatri, le librerie, in sintesi la cultura; poi bar e ristoranti, esercizi commerciali e grande distribuzione; infine, dopo una lunga concertazione con i rappresentanti degli industriali (a oltre un mese dall’istituzione della zona rossa a Codogno), il Governo è riuscito a chiudere una parte delle fabbriche non collegate a produzioni essenziali. Nella fase di riapertura si sta seguendo l’ordine inverso: mentre alcune industrie hanno potuto evitare la chiusura senza previ controlli, altre stanno già riaprendo, secondo una dettagliata tabella di marcia, in previsione del totale ritorno allo status quo ante; tra poche settimane anche le attività commerciali riprenderanno a pieno ritmo, così come chi somministra alimenti e chi svolge servizi alla persona; per le scuole si parla genericamente di una riapertura a settembre, mentre non sono pervenute notizie su cinema, teatri, concerti, o altre iniziative culturali e luoghi connessi alla vita associativa.
È pericoloso far intendere a una popolazione sotto stress che due mesi di quarantena sarebbero serviti solo a non intasare le terapie intensive e a preparare la resilienza (questo significa, la “convivenza col virus”), piuttosto che averli impiegati per programmare una nuova visione dei rapporti produttivi e della società. Con l’aggravante di aver utilizzato strumenti legislativi emergenziali che, in un domani non troppo lontano, potrebbero portare a conseguenze nefaste, in mano a nuovi detentori del potere che riscuotessero il favore di un popolo deluso. Chiudiamo l’ardito parallelo storico rammentando che pure l’Italia del 25 luglio 1943, festeggiando la caduta del fascismo, si attendeva la fine della guerra; per la mala gestione sabauda dei 45 giorni seguenti si ritrovò, di contro, l’occupazione nazista, la serpe in seno della RSI, e i 20 mesi più dolorosi e tragici della sua storia recente.
Se è vero che per affrontare un’epidemia i decisori politici non possono ignorare le ragioni dell’economia, è altrettanto vero che possono ignorare le ragioni del profitto, specialmente quando queste, a medio termine, danneggiano pure le prime, oltreché la convivenza civile.
E se la prossima pandemia colpisse in particolar modo i bambini? O le donne? O chi lavora nei campi? O chi vive nelle città? Difficile prevedere che strada prenderanno le distorsioni di una natura che ci ostineremo a violentare per favorire chi accumula capitale. Un famoso detto dei nativi americani ammonisce: “Solo quando l’ultimo albero sarà abbattuto, quando l’ultimo fiume sarà avvelenato, quando l’ultimo pesce sarà pescato, voi capirete che il denaro non si mangia”.