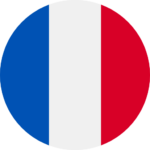L’Antifascismo nacque come reazione, morale e politica, alla dottrina e alla prassi del fascismo, già al suo apparire nel 1919 e proseguì poi per tutto il Ventennio.
Fino alla Marcia su Roma e poi nei primi mesi di instaurazione del regime, l’Antifascismo, godendo di tribuna parlamentare e di una certa libertà di stampa, attuò una’opposizione al fascismo di tipo politico tradizionale.
A seguito del delitto Matteotti del 1924, con la promulgazione delle leggi “fascistissime” del 1925-1926 e lo scioglimento dei Partiti e dei Sindacati non fascisti, l’Antifascismo entrò in clandestinità. Da quel momento la repressione contro gli oppositori al fascismo, attuata dal regime attraverso molteplici strumenti, come il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, il confino politico, l’ammonizione, la sorveglianza e, dal 1940, l’internamento, fu durissima. Per sfuggirvi molti antifascisti, nonostante il divieto di migrazione, furono costretti all’esilio e fuggirono all’estero dove, tra molte difficoltà, diedero vita a diverse forme di organizzazione e di mutuo sostegno, la più nota delle quali fu la Concentrazione Antifascista.
Sia in Italia che all’estero, contro gli antifascisti fu messa in campo una vasta rete di delatori, spie, sobillatori, agenti provocatori organizzati dalla polizia segreta fascista, l’OVRA (Opera Vigilanza Repressione Antifascismo), alla quale si aggiunsero anche persone comuni desiderose di accreditarsi presso il regime.
A partire dagli anni Trenta, movimenti antifascisti si imposero anche nei Paesi dove si affermarono forze politiche riconducibili al prototipo fascista, come l’Austria, la Germania e la Spagna, e con la Seconda Guerra Mondiale, nei Paesi europei occupati dai nazifascisti. Di particolare importanza in questo quadro fu la Guerra Civile spagnola (1937-1939) che contribuì a rinsaldare i rapporti tra le varie esperienze antifasciste nazionali.
In Italia i lunghi anni di carcere e confino a cui furono condannati gli antifascisti significarono spesso, accanto alle numerose sofferenze e privazioni, anche studio, approfondimento e confronto. Produssero una ricchissima letteratura carceraria, il cui esempio più noto sono i “Quaderni del carcere” di Antonio Gramsci. Maturò, cosi, ben presto tra la maggior parte degli antifascisti, la convinzione che dopo il fascismo si sarebbe dovuto edificare uno Stato nuovo e non semplicemente restaurare lo stato liberale: l’Antifascismo si tradusse così in programmi di riforma degli assetti sociali e politici ispirati a una concezione allargata della cittadinanza e dei diritti, alla diffusione del benessere comune ed alla rifondazione o rinnovamento degli ordinamenti democratici nell’Europa postbellica (si veda “Per un’Europa libera e unita”, meglio conosciuto come Manifesto di Ventotene). In questa chiave, in Italia l’Antifascismo non solo animò la Resistenza – i cui quadri politici spesso provenivano dalla precedente esperienza della persecuzione antifascista – ma dopo la Seconda Guerra mondiale, assunse l’orientamento di una cultura politica di promozione e attuazione della Costituzione italiana, opposizione ai progetti di ricostituzione del fascismo storico e, più in generale, a tutti gli atteggiamenti e comportamenti antidemocratici, autoritari e di intolleranza. In questo senso l’Antifascismo, a differenza del fascismo, resta un fenomeno politico vitale e capace di durare nel tempo, oltre la congiuntura storica in cui è nato, in grado di unire, senza cancellare, forze e culture politiche differenti.